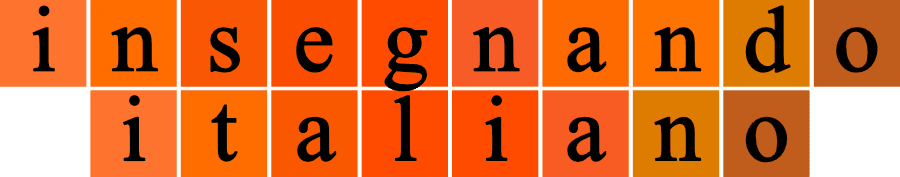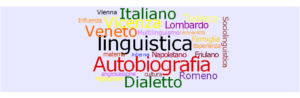Nel momento in cui Le nuove Indicazioni Nazionali stabiliscono che cosa e quanto bisogna insegnare, l’insegnante non può perdere di vista la domanda che da sempre lo tormenta: «Come bisogna insegnare?»
Una risposta originale a questa domanda è data dal film di Alexander Payne “The Holdovers” che racconta il difficile rapporto tra un professore cinico e sprezzante ed uno studente incapace di dominare i suoi violenti scatti di rabbia. Anzi, il titolo italiano “Lezioni di vita” offre allo spettatore una più precisa chiave di lettura per indagare la relazione insegnante – studente.
L’incipit narrativo ci porta in un liceo privato del New England, il prestigioso collegio Barton che ha visto passare molte generazioni di giovani della classe dirigente americana. È l’ultimo giorno di scuola prima delle vacanze di Natale del 1970, quando tutti si preparano a partire. Ma un piccolo gruppo di studenti non può rientrare in famiglia: sono gli “holdovers”, cioè gli avanzi che rimangono nel collegio vuoto, insieme al professore Hunham, alla cuoca Mary e a un bidello.
Mentre il Natale è la celebrazione dei buoni sentimenti e dei legami familiari, i ragazzi e gli adulti con loro vivono l’esclusione dalla festa, la mancanza degli affetti, la rinuncia alle vacanze sulla neve. Sono tutti infelici, ma, come suggerisce Tolstoj, ciascuno lo è a modo proprio. Infatti il film mette in scena tante diverse infelicità che alimentano risentimenti e conflitti; tuttavia nel corso della storia i personaggi abbandonano i loro rigidi schemi di comportamento e si avventurano nella terra incognita delle relazioni umane. Scoprono così, nel calore dell’empatia, una via d’uscita alla loro solitudine. Lasciamoci, dunque, sorprendere da un racconto mai prevedibile e scontato: un occhio ai fatti che succedono e alle “cose” che si vedono, un occhio alle reazioni emotive e ai sentimenti che si generano.
Ma perché proporre la visione di questo film a scuola?
Innanzitutto “Lezioni di vita” è una storia originale, ricca di risvolti psicologici e sociali; ha una sceneggiatura solida e avvincente; ha un ottimo cast di attori, tra cui Da’Vine Joy Randolph, premiata con l’Oscar come migliore attrice non protagonista. Infine, il film non mette in scena una visione idealizzata del mondo e della relazione tra insegnante e studenti. Anzi, il professore Hunham è rappresentato come un tipico antieroe, pieno di difetti che non si preoccupa di nascondere: non fa una vita sociale, ha difetti fisici perché è strabico e puzza, non ha grandi risorse morali; dice infatti: “Non ho un intero libro dentro di me”.
Tuttavia questo personaggio, patetico e ridicolo, avrà il suo riscatto e si trasformerà in un vero eroe. All’inizio la sua figura fa ridere perché lo spettatore percepisce la contraddizione tra ciò che lui vorrebbe essere (un buon insegnante) e ciò che realmente è, “uno stro**o”, come dicono tutti. Infatti il contrasto tra realtà e apparenza, come osserva Pirandello, è il motore della comicità ma lo spettatore ride di lui senza riflettere. Soltanto nel corso della storia si scopre perché puzza, perché è rigido, perché è solo, perché si è costruito una maschera di professore erudito, inflessibile e detestato. E a quel punto scatta l’umorismo perché la riflessione ci porta a comprendere meglio il lato tragico e patetico dietro la comicità del personaggio. Anche lo studente Angus, il co-protagonista del film, dietro una maschera di aggressività e ribellione, nasconde un animo sensibile, ferito nel profondo e in preda a un’angoscia esistenziale. Angus lancia ripetuti segnali di richiesta d’aiuto, ma sia il professore sia lo spettatore che con lui partecipa alla storia non li sanno comprendere. Sarà Mary, la cuoca nera, anche lei ferita da un grave lutto, a spingere il professore sulla strada dell’empatia e ad aprirgli le porte della relazione con Angus.
I rapporti tra i personaggi, le suggestioni e i sentimenti avvincono lo spettatore in una dinamica emotiva che si dipana sempre nuova fino all’imprevisto epilogo. Le “lezioni di vita” impartite dal film riguardano dunque le relazioni umane, in particolare quelle tra adulti e giovani, e rappresentano il principale motivo di interesse per una visione scolastica.
Altri motivi di interesse possono venire dai dialoghi, spesso punteggiati da citazioni e frasi ad effetto che fissano i temi della storia. Ecco alcuni esempi:
– “Non nobis solum nati sumus” “Non siamo nati solo per noi stessi”. La massima di Cicerone è citata con sarcasmo e autoironia dal professor Hunham quando il preside gli comunica che lui dovrà rimanere nel collegio durante le vacanze: di tutti i professori lui è l’agnello sacrificale. Nel collegio Barton nessuno segue questo motto, neppure il professore Hunham, tanto che a metà del film Angus lo rimprovera dicendogli: “Io rischio di perdere il braccio e lei pensa solo a se stesso”. È interessante notare che il motto latino è presente nello stemma di molte università americane e compare spesso in contesti educativi e filantropici perché ricorda il valore dell’empatia e della cooperazione nella società. La massima ciceroniana ci fa riflettere in primo luogo sulla contraddizione tra individualismo e solidarietà che attraversa tutta la società americana e, in generale, quella occidentale. Quando, però, si parla del rapporto educativo questo tema diventa cruciale perché l’insegnamento non è un mero travaso di conoscenze, ma è un prendersi cura di colui che ti è stato affidato. Il film esemplifica la trasformazione del professor Hunham da pedante e spietato professore di storia antica – che dice: «Le avversità forgiano i caratteri» e «L’indulgenza è l’ultima cosa di cui hanno bisogno» – a maestro di vita, disposto a sacrificarsi per la libertà del ragazzo. Ma il prendersi cura dell’altro non è indolore, anzi ha un alto prezzo che il professore è costretto a pagare per la felicità del ragazzo e per il proprio riscatto morale.
– “Entre-nous”: l’espressione francese “tra di noi “, che ritorna più volte nel film, nasce per sigillare un patto di complicità quando i protagonisti iniziano a trasgredire le regole dell’Istituto; in seguito segnala la nascita e lo sviluppo di un rapporto confidenziale più profondo, oltre la rigidità dei rispettivi ruoli. Protetti dalla riservatezza, i personaggi gettano le maschere e si confidano le loro debolezze e sofferenze.
– “Per molte persone la vita è come la scaletta di un pollaio: corta e piena di me**a. Lei è stato baciato dalla sorte. Forse un giorno voi piccoli degenerati lo apprezzerete…” Il professor Hunham reagisce con questa frase all’ atteggiamento sprezzante di uno di loro nei confronti della cuoca Mary e vuole far capire a tutti il privilegio di avere una famiglia facoltosa e la possibilità di frequentare una scuola prestigiosa. Questo è uno dei pochi accenni espliciti alla denuncia sociale, anche se in tutto il film si respira l’aria della rivolta degli anni Settanta, della guerra in Vietnam e del contrasto tra le classi sociali. Se gli adulti del film appartengono alla classe medio-bassa, come il professore e l’impiegata, o alla classe più bassa, come la cuoca e il bidello, gli studenti sono invece tutti rampolli della classe dirigente. Tuttavia il film non alimenta ingenue speranze in un cambiamento delle dinamiche sociali. Anzi l’ambientazione della storia cinquant’anni prima permette allo spettatore di oggi di capire che nulla è cambiato nella società americana.
In conclusione “Lezioni di vita” , costruito attorno alle dinamiche emotive dei personaggi, si fa apprezzare per la capacità di sorprendere e di commuovere lo spettatore.